
Hisayasu Sato è un regista strano, molto strano: è un uomo dotato di una profondissima sensibilità, deviato da traumi infantili e sessuali su cui è meglio non divagare, è una personalità insolita all’interno del cinema giapponese. é un nome che più volte si tira fuori per definire quel sottogenere del cinema asiatico che prende il nome di “Cinema estremo”: in realtà, il cinema di Sato è tutto fuorché tette e sangue.
Hisayasu Sato è tutto fuorché un pervertito. Regista spesso sfortunato, poco considerato e diventato celebre solo con il caposaldo “Naked Blood” (1995), film splatter filosofico che riflette sull’impossibilità della cancellazione del dolore nell’essere umano, è in realtà un artista con alle spalle quasi un centinaio di film. Personaggio enigmatico, ambiguo, eppure capace di grandi cose. E, tra queste grandi cose, sicuramente c’è “Muscle“: il suo capolavoro, un film splendido e perfetto in ogni sua componente, che ancora una volta sfrutta il genere del “pinku-eiga” (il cinema softcore nipponico a basso budget) per avere la massima libertà d’espressione, sia visiva che narrativa.
Ma “Muscle” è, prima di tutto, una potentissima storia d’amore e cinema. Film breve ed intenso, lento, dolorosissimo e, a tratti, persino estenuante, che riflette, con una potenza inarrivabile sia sul rapporto di coppia, che sul rapporto con il cinema. Il cinema è visto come uno strumento di altissima capacità, di massima comunicazione e di interazione (“Se non ti piace quel che vedi, allora non pagare”), o come unione degli affetti interpersonali (il protagonista che vuole vedere “Salò O Le 120 Giornate Di Sodoma” per riallacciarsi ad una persona cara, che gli aveva parlato del film stesso), un senso metafilmico che si riallaccia perfettamente alla visione distorta e sconcertante dell’amore, secondo l’autore asiatico: in una società sull’orlo del collasso, soffocata dal desiderio del possesso e della perversione, solo i puri di cuore credono ancora nell’amore. E i puri di cuore sono destinati a soffrire.
Per questo anche l’azione, che è il letmotiv del film (ritrovare il proprio amante per restituirgli il braccio amputato), sotto la crosta del grottesco e del disturbante, nasconde una metafora splendida sull’amore: per amare bisogna raccogliere i pezzi che hanno portato alla rottura del rapporto e rimetterli insieme. Per amare bisogna dimenticare il corpo, accecandosi, e iniziare a sessualizzare l’anima.
I personaggi di Sato sono sempre persone vuote, che cercano disperatamente qualcosa che possa riempirle: sono automi senza volto, disperate cornici del nulla, vaganti spaventapasseri in mezzo a soffocanti vie metropolitane. I personaggi di Sato cercano nel sesso l’unica via possibile verso la catarsi, ma non la trovano quasi mai: la speranza risiede in un non-luogo, in un limbo dove finalmente potersi raccontare.
E qui entra in gioco il lunghissimo, straordinario finale, che pare anticipare di oltre dieci anni l'”Eyes Wide Shut” kubrickiano: un dolente e morbosissimo festino sessuale che si trasforma in farsa teatrale, dove tutti i nodi vengono al pettine, e dove solo un’azione estrema può ricongiungere due persone che si amano, ma che non vogliono rendersene conto.
è lo sguardo, criptico, disilluso e vertiginoso di Hisayasu Sato: un pugno in pieno viso che si concretizza in un cammino che sprofonda negli inferi, nelle viscere, subliminando ciò che è inconscio in tutti noi. è un viaggio che vive di morte, arte, sesso, amore, vita. E ciò che può essere considerato estremo, impossibile o violento, non è altro che la nostra vita.
Per amare, si deve ballare, ad occhi chiusi, un tango sfrenato.







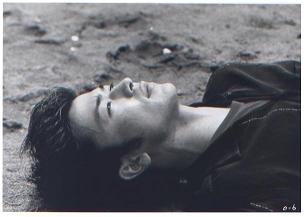
.jpg)













